"COLERA MORBUS"
Lutto, e non solo, a Gesualdo Luglio-Settembre 1837
di Franco Caracciolo

Come recitava nella sua classica "A livella" Totò, il pensiero di onorare
adeguatamente i morti almeno il due novembre, quest'anno, l'ha tenuta la neo
amministrazione comunale di Gesualdo (Av).Il Sindaco, l'Avvocato Nuccio Petruzzo,
lo ha fatto nella maniera più nobile; onorando i morti "maledetti", da secoli
dimenticati.Sono i morti a causa del "Colera Morbus" che, proveniente
dall'oriente,invase l'Europa e l'Italia, flagellando, dal 1835 al 1837, regni,
ducati e
stati invadendo per prima il nord per
propagarsi, senza alcun frenopossibile, fino alla Sicilia. A Gesualdo vi arrivò
nel 1837 alla vigilia della prima fiera di Luglio e ci furono morti fino al mese
di Settembre dello stesso anno; le vittime furono 130. Lo sono ancora, così come
lo furono, sepolte nella nuda terra, "feletta", ai confini del territorio
comunale, come imponevano le leggi francesi introdotte nel regno da Giocchino
Murat, secondo l'editto di Saint Claud di qualche lustro prima..
Di questi, forestieri o paesani che siano, anche lo "storico don Giovanni abate
Catone" ne fa solo cenno , questa volta in maniera esatta, elencando solo
qualcuno, ignorando, secondo la mentalità aristocratica dell'epoca, la
totalità dei nomi, nelle sue "Memorie Gesualdine" (quasi sempre
imprecise,approssimative e prezzolate): ". D. Raffaele Nocera; tolto
a' vivi dal Colera del ricordevole 1837.. ". Quei morti, insieme ad altri
ammalati che
invece se la cavarono, stazionarono, da vivi, in un "casino di
quarantena"(lazzaretto) situato nel mezzo di un bosco di querce, oggi agro di
Frigento,a circa cento metri ad est dal luogo della sepoltura. Il giorno di
tutti i
santi, alle ore 16:30 la cerimonia di commemorazione. Ufficiata sul luogo una
messa solenne dal prete Don Aberico Grella da Sturno, in suffragio di quelle
povere anime, presenziata dal Sindaco e dai consiglieri di maggioranza, nonché
da una moltitudine di persone sensibili e commosse alle parole dell'Avvocato
che, nel suo discorso, ha ricordato il motivo di quel
gesto tanto simbolico, quanto sentitamente dovuto, ringraziando tra gli altri
anche il direttore del sito
http://carlogesualdo.altervista.org , Franco Caracciolo, per alcune
ricerche svolte (130 morti per colera nel
1837). Quel luogo però non è da confondersi con "cippi, stele" e dicerie,come
quella di "Cimitero vecchio" perché, lo era tale invece, il territorio
sottoposto alla chiesa della "Congregazione", già "Addolorata e Morti",
quella che oggi risulta affrescata anche dalla francese Caty Toma, ubicato
praticamente appena fuori le mura di Gesualdo nelle adiacenze del
PortoneLudovisi, a cento metri "dall'ospedale di Cammarino". Come ha ricordato
Petruzzo, il luogo, per secoli, è restato abbandonato a se stesso, senza alcun
segno di distinzione o di citazione, ed era ridotto soltanto a pascolo ovino.
Oggi, grazie all'impegno dell'Avvocato e primo cittadino, è stato
riqualificato con una targa alla memoria, i lavori sono stati eseguiti e diretti
personalmente dall'assessore Gallo Pietro su delega del sindaco.
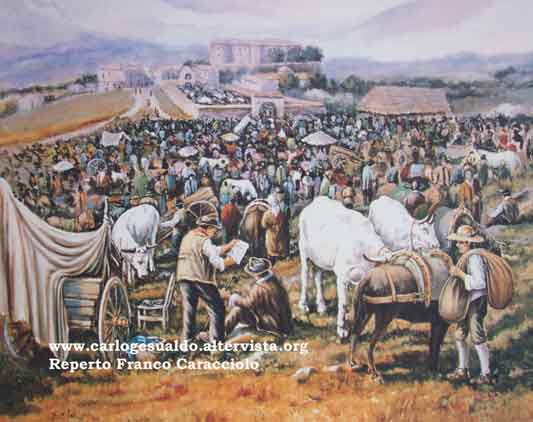 Quell'evento fu
una vera disgrazia per Gesualdo perché si verificò durante il periodo più
delicato dell'anno per le attività economiche e commerciali del paese, che
ruotavano principalmente, fin dal 1400/1500, intorno alle
Quell'evento fu
una vera disgrazia per Gesualdo perché si verificò durante il periodo più
delicato dell'anno per le attività economiche e commerciali del paese, che
ruotavano principalmente, fin dal 1400/1500, intorno alle
fiere "di primo ordine" che si svolgevano a Gesualdo. Esse facevano da snodo per
le fiere più importanti di Salerno, Benevento, Foggia, Gravina, Aquila e
Campobasso. Non erano solo semplici mercati dove si vendevano merci di ogni
genere ai consumatori ma erano luoghi di scambio fra mercanti provenienti da
regioni lontane. Cereali, bestiame, seterie, pannine, oro e argento lavorato,
generi coloniali, chincaglierie, utensili da lavoro, lane, cuoi e pelli
lavorate,
vino ed altre merci si presentano, si acquistano e si pagano solitamente nella
fiera successiva. L'esteso bosco delle c/de Maddalena, di Torre dei Monaci, di
Torre dell'Agno adiacenti al tratturo foggiano, nonché delle aree adiacente al
tratturo napoletano di Torre dei Bianco e Taverna dei Rossi di Gesualdo, e di
Migliano di Frigento offrono gratuitamente, come da
tradizione antichissima, erba ed acqua agli animali in transito. In quelle fiere
così articolate non poteva mancare un ordine giuridico rigorosamente costituito.
Esso era, appunto, assicurato negli itinerari e strade d'accesso da milizie
provinciali, da armigeri, dal controllo dei passi e delle strade, da
salvacondotti, ecc.. Il fulcro delle Fiere era un granderecinto rettangolare che
funge da unico fondaco protetto: oltre 3.400 metriquadrati, con più di 130
piccoli "stend" (punti vendita) lungo il perimetro interno, più una moltitudine
di baracche di interesse minore sparpagliate nell'immenso "cortile". La notte si
chiudono, a difesa, i due cancelli d'entrata per riaprirsi la mattina, a nord
verso frigento le mandrie ancora
commerciabili ne presidiavano l'ingresso espandendosi per tutto il Piano
S.Filippo. I mercatari che fittano le baracche costituisco il maggior introito
per il bilancio comunale (circa 8 ducati per ogni "stend", poco meno del
costo di un vitello adulto). Altre "Terre" debbono arrancare per soddisfare il
fisco, Gesualdo non ha deficit di sorta, le tasse comunali sono ridotte al
minimo e di poca entità, non colpiscono i contadini poveri e le attività
produttive. La durata delle fiere è di giorni tre, "esclusi quelli que' che le
precedono prima di assembrarsi per la validità de' contratti, e quelli
che le seguono detti giorni di sfratto" come scrive l'abate
( 1 ). Praticamente la permanenza a Gesualdo era minimo di due
settimane tra arrivo e ripartenza delle maestranze. Un mastro di fiera, nominato
dai locali amministratori, esercita la giustizia civile e criminale durante il
suo svolgimento. Questi cura l'ordine pubblico (la cosiddetta "pace di
fiera")con milizie provinciali e locali, i cosiddetti "mazzieri". controlla i
prezzi, la qualità del foraggio e degli alimenti somministrati nelle taverne
e annota in un registro tutti coloro che sono ospitati da privati. Notai della
provincia del Principato Ultra e l'Udienza di Montefusco, accertano le lettere
di cambio nei giorni che precedono la fiera e ne roborano gli atti durante lo
svolgimento. Una messa è celebrata ad ogni apertura di fiera nella cappella
dell'Annunziata, collocata in alto sul portone dell'ingresso
principale rivolta all'interno del grande recinto. Le fiere sono quelle
dell'Annunziata, della Maddalena, dell'Assunta, di Santa Croce, di SantaLucia,
distribuite tra il mese di Marzo e Dicembre, rendendo la cittadina un centro
commerciale di grande interesse. Un'epigrafe del 1578, collocata sul portone
principale dell'ingresso fieristico ricorda la battaglia vinta dall'Università"
contro le pretese del principe Fabrizio Gesualdo a mettervi le mani.
 Gli stessi
Celestini, con i loro locali a pian terreno, e il Principe con l'ex
cavallerizza, hanno proprie taverne per ospitare uomini, cose e animali. Il
paese e gli svincoli nelle campagne adiacenti alcentro urbano, e alla fiera è
disseminato da punti di ristoro e di ricovero
Gli stessi
Celestini, con i loro locali a pian terreno, e il Principe con l'ex
cavallerizza, hanno proprie taverne per ospitare uomini, cose e animali. Il
paese e gli svincoli nelle campagne adiacenti alcentro urbano, e alla fiera è
disseminato da punti di ristoro e di ricovero
per persone e animali, da Pagliaroni costruiti in pietra e coperti di paglia , a
Locande e Taverne rimaste improvvisamente deserte in quella maledetta estate del
1837. . Mentre il "Colera Morbus" prendeva le sue 130 anime,
purtroppo si aprivano forse, per Gesualdo, le porte ad una sorta di decadenza
epocale della ridente cittadina, si determinando forse nuovi eventi e nuovi
scenari politici e amministrativi. Un decadimento protrattosi, come una
maledizione e per alcuni aspetti, fino ai giorni nostri. Andrà ancora oltre? A
Gesualdo, insieme ai mercanti giungevano,transitavano o si fermavano per sempre
anche artigiani, prestatori di danaro, artisti, ciarlatani, giocolieri,
cavadenti, ladri, vagabondi, storpi
e poveri questuanti, manovali, galantuomini oziosi, scapoli in cerca di moglie e
gente in cerca di fortuna. Allora Gesualdo era città aperta e i forestieri erano
i ben venuti, visti di buon occhio, come una ricchezza da sfruttare e
salvaguardare senza le ataviche paure verso gli stranieri. A Gesualdo si è
andata formando,allora, una società multi etnica, i cui cognomi ricordano quelli
frequenti in città mercantili e produttive d'Italia e nelle regioni meridionali,
nonché di greci, albanesi, slavi e ebrei espulsi dalla Sicilia e dalla Spagna a
fine 1400, un fenomeno che si èchiuso praticamente ai giorni nostri, quasi
definitivamente una quarantina di anni fa. Tra questi parenti ed affini,
misericordiosamente deposti, là dove una targa ne vuole eternizzare e preservare
il riposo eterno. Antenati di un mondo che esiste ancora e che oggi come allora
lotta, cade e risorge per seguire una strada sapientemente e sacrificatamene
segnata.
(Gesualdo 01 Novembre 2005).
( 1 )
Da Gesualdo e il Principe dei Musici (Associazione Culturale
Centro Studi
e Documentazioni Carlo Gesualdo)





